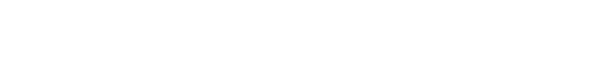Con la recente sentenza C-527/15 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce la violazione del copyright dei gestori di “The Private Bay”, portale per la condivisione di file in rete. I diritti d’autore sarebbero infranti anche se a caricare i file sono persone terze, gli utenti, poiché “gli amministratori di Pirate Bay non possono ignorare il fatto che tale piattaforma dà accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti”.
Le argomentazioni utilizzate dai giudici della Corte per condannare Pirate Bay sono rivoluzionarie rispetto alle logiche che finora hanno consentito lo sviluppo del business di questi operatori.
In particolare, la Corte di Giustizia ha stabilito per prima cosa che i gestori delle piattaforme di condivisione pongono in essere, attraverso la loro attività, una forma di comunicazione al pubblico che, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE, deve essere autorizzata dal titolare dell’opera oggetto della comunicazione. Infatti, gli amministratori, pubblicando i contenuti caricati dagli utenti, svolgono “un ruolo imprescindibile” nella loro messa a disposizione, ad esempio indicizzando e gestendo i vari file e suddividendo in categorie le opere disponibili ed eliminando i file vecchi ed obsoleti. Infine, ha sottolineato la Corte UE nelle sue osservazioni, i siti di condivisione rispondono anche perché dalla pubblicazione di questi file si generano introiti pubblicitari considerevoli.
È evidente che questa sentenza chiama in causa tutti i gestori di piattaforme di condivisione online e fa sorgere in capo a questi una maggiore responsabilità in caso di contenuti illegali caricati dagli utenti.
Secondo alcuni esperti, però, la sentenza avrà ripercussioni non tanto nel mondo della pirateria, quanto nel settore della condivisione di video legale e in quello dei social network. Infatti, l’aver affermato che la messa a disposizione di opere in una piattaforma di condivisione costituisce una comunicazione al pubblico ha più effetti nei confronti delle piattaforme di condivisione gratuita, come ad esempio Youtube, che fanno parte dei cosiddetti User Generated Content (UGC) e che il più delle volte utilizzano lo strumento dello streaming, piuttosto che nei confronti della pirateria vera e propria. Il rischio è dunque quello di procedere ad una troppo semplice assimilazione dei siti UGC alla categoria degli antiquati siti di downloading di torrent come, appunto, Pirate Bay.
L’affermazione in base alla quale infatti il gestore è responsabile qualora intervenga gestendo e filtrando attivamente determinati contenuti, sembra prefigurare una diretta e generale responsabilità per l’immissione in rete di contenuti ad opera di terzi.
Il dibattito europeo sarà fortemente influenzato da questa decisione, anche perché proprio in questi giorni il Parlamento Europeo sta lavorando alla riforma sui copyright e la relativa responsabilità delle piattaforme online.