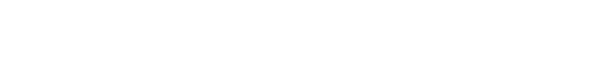L’azienda dello stilista newyorkese Thom Browne (dal 2018 parte del Gruppo Ermenegildo Zegna) ha recentemente avuto la meglio in un contenzioso promosso da adidas innanzi al Tribunale del Distretto sud di New York per tutelare il proprio famoso marchio costituito dalle caratteristiche tre strisce parallele. Il tribunale americano ha infatti riconosciuto che Thom Browne, stilista conosciuto per i suoi capi di abbigliamento sartoriali di alta gamma, non ha commesso alcuna violazione dei diritti di marchio della multinazionale tedesca nell’apporre sui propri capi di abbigliamento e modelli calzature un motivo costituito da quattro strisce parallele.
In realtà, il contenzioso in materia di marchi tra le due aziende pendeva già da qualche anno. Infatti, già 2018 adidas aveva avviato innanzi all’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) un’opposizione contro una domanda di marchio comunitario depositata da Thom Browne per tutelare un segno costituito da quattro strisce parallele. A tale opposizione ne erano poi seguite nel 2020 altre innanzi allo United States Patent and Trademark Office con cui adidas aveva contestato tre domande di marchio aventi ad oggetto strisce rosse, bianche e blu destinate a contraddistinguere le calzature prodotte dallo stilista newyorkese. adidas riteneva infatti che tutti i sopra menzionati marchi di cui Thom Browne aveva chiesto la registrazione fossero confondibili con le proprie registrazioni anteriori rivendicanti, appunto, le famose tre strisce.
Tornando all’attuale decisione della corte distrettuale di New York, nel giugno del 2021 il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo aveva intentato una causa contro Thom Browne sostenendo che l’utilizzo da parte di quest’ultimo di un segno costituito da strisce parallele violasse i propri diritti di marchio, oltre a costituire un’attività di concorrenza sleale confusoria nell’ambito dell’abbigliamento sportivo.
L’azienda tedesca sosteneva infatti che l’utilizzo da parte di Thom Browne di un marchio simile al proprio celebre marchio a tre strisce utilizzato da oltre cinquant’anni adidas, ingenerava confusione nei consumatori sull’origine dei prodotti stessi, o che comunque li inducesse a credere che tra le due aziende vi fosse una qualche collaborazione o affiliazione. In particolare, adidas contestava a Thom Browne l’utilizzo delle strisce in modalità similari al proprio marchio a tre strisce, creando così confusione sia nell'aspetto estetico che nell'impressione commerciale complessiva che tali prodotti fornivano. adidas sosteneva che, in particolare i prodotti nella categoria dell'abbigliamento e delle scarpe sportive fabbricati dall’azienda americana, fossero identici alle medesime categorie di prodotti da tempo contraddistinti sul mercato dal proprio marchio a tre strisce.
A parte gli evidenti elementi di similarità dei marchi dei due contendenti, l’impianto accusatorio di adidas era inoltre fortemente incentrato sull’elemento concorrenziale perché, per fondare la propria richiesta risarcitoria di circa 8 milioni di dollari, l’azienda tedesca aveva evidenziato al giudice statunitense che Thom Browne non si limitava al solo utilizzo delle quattro strisce nel proprio core business, ovvero l’abbigliamento di alta moda, ma stava invadendo in modo sempre più aggressivo il segmento dell'abbigliamento sportivo ed in genere i settori dove adidas è leader di mercato. E ciò non solo con l’ampliamento della propria gamma di abbigliamento sportivo, ma anche tramite accordi promozionali come ad esempio quello concluso da Thom Browne con il famoso club spagnolo del F.C. Barcelona.
Eccependo la totale differenza tra i rispettivi canali distributivi del luxury e dello sportswear, nonché dell’ampio divario tra i prezzi dei rispettivi prodotti, la tesi difensiva dell’azienda americana era ovviamente incentrata sull’insussistenza di qualsiasi rischio di confusione per i consumatori. Forse più interessante e meno scontato è quanto inoltre argomentato dalla difesa di Thom Browne nel rilevare come adidas abbia aspettato molto tempo prima di intraprendere un'azione legale contro il proprio utilizzo delle strisce. Come già avvenuto precedentemente in altre sedi, anche davanti alla corte newyorkese Thom Browne ha evidenziato come adidas già nel 2007 avesse immediatamente contestato l'uso di Thom Browne di tre bande orizzontali sui propri capi di abbigliamento, ma abbia poi invece tollerato per molto tempo l'uso di quattro bande orizzontali parallele sui capi di abbigliamento che successivamente Thom Browne aveva appositamente intrapreso proprio per allontanarsi quanto più possibile dai marchi dell’azienda tedesca.
In sostanza, Thom Browne ha quindi sostenuto che il ritardo di adidas nell’intervenire per impedirgli di utilizzare il proprio marchio a quattro strisce è stato irragionevolmente lungo in quanto il colosso tedesco dello sportswear sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che Thom Browne utilizzava un design a quattro bande orizzontali. Per la difesa dello stilista newyorkese, ciò avrebbe peraltro anche costituito un’implicita dimostrazione che i rispettivi marchi a strisce sono di fatto coesistiti sul mercato per molto tempo senza che adidas avesse subito alcun danno. Se da una parte Thom Browne ha ovviamente accolto con favore la propria assoluzione facendo notare come da oltre vent’anni anni la propria azienda sia un brand innovativo nel segmento della moda di lusso, dove propone un design del tutto unico e distintivo che combina la sartoria classica con la sensibilità dell'abbigliamento sportivo americano. Dall’altra, adidas ha già dichiarato che impugnerà la sentenza della Corte distrettuale di Manhattan, decisione che non a caso si aggiunge ad altre negative subite dalla multinazionale tedesca in sede EUIPO e che hanno già messo in discussione il carattere distintivo del proprio marchio a tre strisce.